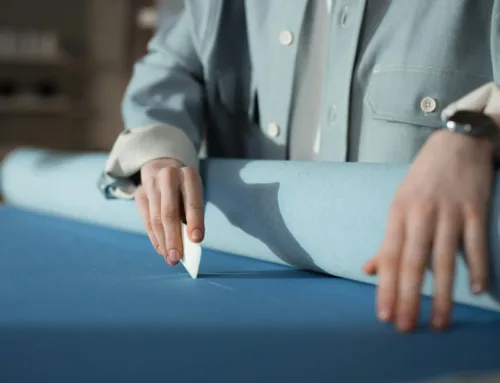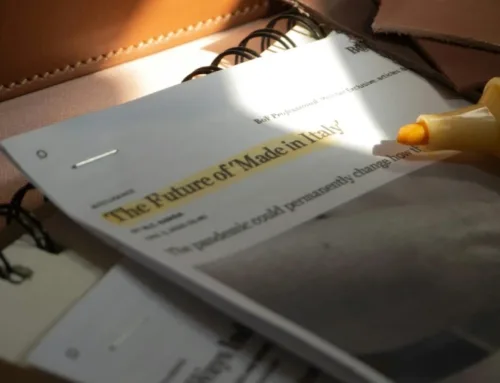Life Cycle Assessment: una metodologia tra sfide ed opportunità
di rén collective

Art. 51/2025 – Responsabile editoriale: Lorenza Vacchetto
Di Mariachiara Volpe e Roberto Chirone
Quando parliamo di sostenibilità nel settore tessile – moda, spesso ci imbattiamo in dichiarazioni generiche, etichette accattivanti e promesse difficili da verificare. Ma esiste davvero uno strumento in grado di misurare con precisione scientifica l’impatto ambientale di un prodotto? La risposta, se vogliamo essere onesti, è dipende. Nessun metodo è privo di limiti e/o sbavature. Tuttavia, tra tutti gli approcci disponibili, il più riconosciuto a livello internazionale, e il più robusto dal punto di vista metodologico, è la Life Cycle Assessment (LCA), ad oggi l’unico strumento che consente di distinguere la sostenibilità come slogan dalla sostenibilità come misurazione oggettiva.
Cosa significa “Life Cycle Assessment”?
La traduzione in italiano di Life Cycle Assessment è ‘Valutazione del Ciclo di Vita’. La LCA è un metodo scientifico standardizzato (ISO 14040/14044) che permette di valutare l’impatto ambientale di un prodotto o servizio lungo tutte le sue fasi del ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino alla fine del suo ciclo di vita.

Nel panorama attuale della sostenibilità nel settore tessile e moda, sono numerose le etichette ambientali di tipo I e II disponibili sul mercato. Questi strumenti, sebbene utili per comunicare informazioni ambientali ai consumatori, forniscono spesso dati qualitativi o parziali, focalizzandosi su aspetti specifici come il contenuto di materia riciclata, la riciclabilità del prodotto, l’assenza di sostanze pericolose o la riduzione dell’uso di risorse. Tuttavia, pur offrendo una prima indicazione sul profilo ambientale di un prodotto o servizio, non forniscono una valutazione quantitativa e complessiva del reale impatto ambientale.
È in questo contesto che la LCA si distingue come lo strumento più robusto, trasparente e scientificamente accreditato per misurare la sostenibilità ambientale. A differenza di indicatori specifici, come la Carbon Footprint — che si concentra sulle emissioni di gas serra — o la Water Footprint — che considera esclusivamente i consumi idrici — l’LCA offre una valutazione complessiva, analizzando l’intero ciclo di vita del prodotto attraverso molteplici categorie di impatto ambientale. Ne deriva una visione sistemica e integrata, fondamentale per comprendere la reale portata delle scelte progettuali.
Prendiamo, ad esempio, una maglietta in cotone. La LCA consente di quantificare l’impatto ambientale associato a ciascuna fase di vita: dalla coltivazione del cotone (con i relativi consumi idrici e l’uso di fertilizzanti e pesticidi), alla filatura e tessitura (energia consumata, scarti generati), alla tintura (impiego di sostanze chimiche e consumo d’acqua), al confezionamento e trasporto (emissioni climalteranti), fino all’uso da parte dell’utente finale(lavaggi, asciugatura) e al fine vita (riciclo, incenerimento o smaltimento in discarica).
Mentre un’etichetta potrebbe indicare la riciclabilità del capo o l’assenza di determinati composti chimici, solo la LCA è in grado di offrire una misurazione oggettiva, comparabile e verificabile dell’impatto ambientale complessivo, tenendo conto della complessità dei processi e delle interazioni tra le diverse fasi.
Quando nasce la LCA?
L’origine di questa metodologia di analisi risale agli anni ’60 e ’70, e nasce inizialmente come semplice analisi di materiali ed energia, promossa soprattutto in ambito accademico ed aziendale negli Stati Uniti. Tuttavia, dagli anni ’90, con la pubblicazione delle norme internazionali ISO 14040 (prima versione nel 1997, aggiornata nel 2006) e ISO 14044 (pubblicata nel 2006), l’LCA acquisisce struttura e rigore metodologico, diventando una prassi consolidata e standardizzata a livello internazionale. Le norme ISO 14040 e 14044 forniscono indicazioni chiare riguardo ai principi generali, alla definizione delle fasi di studio (obiettivo e ambito, analisi dell’inventario, valutazione dell’impatto e interpretazione) e ai requisiti tecnici specifici per assicurare la qualità e trasparenza dell’analisi. Queste norme indicano concretamente come raccogliere e trattare dati precisi e affidabili riguardo a ciascuna fase del ciclo produttivo e distributivo, dal campo fino alla gestione finale del prodotto dismesso.
Perché il settore tessile ha bisogno della LCA?

Il settore tessile è uno dei più rilevanti in termini di impatto ambientale globale, a causa dell’alto consumo di risorse idriche ed energetiche, delle elevate emissioni di gas serra e dei significativi volumi di rifiuti prodotti. Secondo il Parlamento Europeo, rappresenta il quarto settore più impattante sull’ambiente in Europa dopo: alimentare, edilizia e trasporti (dati 2020). Un’applicazione rigorosa della LCA nel settore tessile permette di identificare chiaramente le fasi più critiche dal punto di vista ambientale, note anche come “hotspot”, e suggerisce dove è prioritario intervenire, orientando le decisioni verso pratiche più sostenibili in ambiti come l’approvvigionamento dei materiali, la produzione e la progettazione dei prodotti. Inoltre, l’analisi del ciclo di vita convalida le affermazioni “green”, garantendo trasparenza e credibilità, oltre ad aiutare le aziende a rispettare normative ambientali sempre più stringenti.
Regolamentazioni attuali
L’Unione Europea, attualmente, promuove fortemente l’adozione della LCA attraverso il Green Deal (lanciato nel 2019), il Regolamento Ecodesign (ESPR) ed il successivo Product Environmental Footprint (PEF), strumenti regolatori che obbligano le aziende tessili a comunicare il proprio impatto ambientale in modo chiaro, trasparente e verificabile.
Normative attuali e in arrivo: etichette ambientali, regolamenti sulla trasparenza e tracciabilità della filiera
Tra le normative più rilevanti, vi è l’introduzione obbligatoria dell’etichettatura ambientale (prevista nel Regolamento Ecodesign per i prodotti sostenibili – ESPR, per cui, il 16 aprile scorso, la Commissione europea ha adottato il piano di lavoro 2025-2030, che richiede la comunicazione dei dati relativi a specifiche categorie d’impatto come emissioni di CO₂, consumo idrico e rilascio di sostanze chimiche ed impone standard rigorosi sulla trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva. Nel documento pubblicato, i prodotti appartenenti al settore tessile e abbigliamento vengono considerati dotati di “elevato potenziale per migliorare l’estensione del ciclo di vita del prodotto, l’efficienza dei materiali e ridurre l’impatto su acqua, produzione di rifiuti, cambiamenti climatici e consumo energetico”.
Trovate maggiori informazioni sul piano di lavoro 2025-30 qui: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1071
Le nuove normative PEFCR per il tessile
La Commissione Europea ha sviluppato, come già citato sopra, una bozza delle Regole di Categoria dell’Impronta Ambientale del Prodotto (PEFCR) specifica per il settore dell’abbigliamento e delle calzature. L’obiettivo è fornire linee guida armonizzate per misurare e comunicare la performance ambientale dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita. Il PEF si basa sull’approccio dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA), e valuta 16 indicatori ambientali, tra cui cambiamenti climatici, uso dell’acqua, uso del suolo e salute umana, per garantire una valutazione completa degli impatti ambientali, e considera 13 sottocategorie di prodotti: t-shirt, camicie e bluse, maglioni e capi intermedi, giacche e cappotti, pantaloni e pantaloncini, vestiti, gonne e tute, leggings, calze, collant e calzini, biancheria intima, costumi da bagno, accessori d’ abbigliamento, scarpe aperte, scarpe chiuse, stivali.
Le nuove PEFCR, approvate dal Technical Advisory Board nel marzo 2025 e in attesa di pubblicazione in Aprile 2025, rappresentano la base metodologica che le aziende dovranno seguire per allinearsi al quadro normativo europeo e ottenere riconoscimenti ufficiali nella comunicazione dei propri impatti. Approfondimenti disponibili su: https://pefapparelandfootwear.eu/
La questione delle microplastiche
Sebbene le microplastiche rappresentino una delle preoccupazioni ambientali emergenti più rilevanti, non esiste ancora una metodologia scientificamente consolidata e standardizzata per valutarne l’impatto sulla salute umana e sugli ecosistemi nell’ambito della metodologia LCA. A differenza, ad esempio, delle emissioni climalteranti, per cui esistono soglie planetarie condivise, non è ancora stata definita una “planetary boundary” per le microplastiche. Nel contesto delle LCA business-to-business, il tasso di rilascio delle microfibre può essere inserito come indicatore, ma tale approccio si rivela inadeguato per le LCA orientate all’utente finale, poiché privo di un riferimento oggettivo sul significato del dato rispetto al rischio effettivo. Dire che una maglietta rilascia “X grammi di microfibre per lavaggio” è informazione incompleta, se non si accompagna a un quadro scientifico sul potenziale danno biologico.
I recenti studi di settore sottolineano un aspetto fondamentale troppo spesso ignorato: la maggior parte delle microplastiche non deriva dal lavaggio domestico, ma dalla frammentazione nel tempo dei rifiuti tessili sintetici mal gestiti, abbandonati nell’ambiente. In particolare, il 98% delle perdite di plastica dall’industria dell’abbigliamento avviene in forma di macroplastiche, che si degradano progressivamente in micro e nanoplastiche, contribuendo a un inquinamento persistente, diffuso e praticamente irreversibile.
Inoltre le LCA attuali e le proposte PEF (Product Environmental Footprint) dell’UE e della Francia sono ancorate ad una visione riduttiva e obsoleta, focalizzata esclusivamente sul rilascio di microfibre durante il lavaggio domestico e sull’impatto marino. Tale approccio è scientificamente inadeguato e non rappresenta in alcun modo la reale entità e complessità del problema.
In sintesi, se vogliamo affrontare seriamente la questione delle microplastiche, è necessario un cambiamento radicale nel modo in cui le LCA vengono strutturate: includere il rilascio da rifiuti plastici tessili, distinguere chiaramente tra fibre sintetiche e naturali, e basarsi su dati scientifici solidi, non su compromessi di filiera o pressioni industriali.
Fonti:
-
The Microfibre Consortium
-
https://baumwollboerse.de/wp-content/uploads/2025/03/BWB_Studie_2025_P5.pdf
Materiali innovativi
La Life Cycle Assessment diventa cruciale nella valutazione di materiali tessili innovativi, che spesso non dispongono ancora di un profilo ambientale consolidato. Nel caso in cui si scelga di produrre un capo utilizzando materiali alternativi, come biomateriali derivati da scarti agricoli, la metodologia LCA consente di individuare i benefici ambientali, o i possibili limiti, di tali soluzioni, rispetto ai materiali tradizionali. Questi ultimi includono fibre naturali, artificiali e sintetiche, e sono al centro di un acceso dibattito internazionale proprio in merito alle comparazioni basate su studi LCA.
Un tema che approfondiremo nel prossimo articolo di trénd.
Limiti e sfide della LCA nel settore moda

Pur rappresentando un approccio estremamente valido e completo, la LCA presenta alcune sfide che devono essere affrontate per garantirne efficacia e affidabilità:
- Complessità e difficoltà nella raccolta e standardizzazione dei dati dovuti prevalentemente a catene del valore lunghe e frammentate, spesso distribuite su scala globale.
- Ampio ricorso a dati secondari generici (es. database ecoinvent, Gabi), spesso poco rappresentativi e difficoltà nel collegare impatti ambientali alla durabilità, qualità o frequenza d’uso del prodotto.
- Trattamento delle microplastiche e dei trattamenti chimici, con mancanza di modelli matematici adeguati alla definizione causa-effetto.
- Le scelte di normalizzazione e pesatura delle categorie d’impatto possono distorcere i risultati, soprattutto nei PEF con il rischio di produrre confronti fuorvianti tra materiali senza considerare aspetti come biodegradabilità, tossicità, circolarità reale (es. cotone vs poliestere).
- Potenziale rischio di greenwashing, se la comunicazione dei risultati non avviene in maniera trasparente e rigorosa.
- Difficoltà nella comunicazione chiara e comprensibile dei risultati tecnici agli utenti finali.
Per affrontare queste sfide è indispensabile migliorare costantemente le metodologie, aggiornare i database, integrare nuove categorie d’impatto (es. biodiversità e microplastiche) e sviluppare strumenti di comunicazione semplificata ma scientificamente solida, attraverso la formazione consapevole dei diversi stakeholder di filiera.
LCA come leva nei bandi e nelle opportunità di finanziamento
La sostenibilità costa, ma oggi viene supportata.
Sebbene le attività legate alla valutazione ambientale — come gli studi LCA o l’ottenimento di certificazioni — siano attività tecniche specialistiche e apparentemente costose, esistono oggi numerose opportunità di finanziamento pubblico che possono abbattere in modo significativo i costi per le aziende. Bandi ed incentivi, sia europei che nazionali, stanno premiando le realtà industriali, incluse quelle del tessile e della moda che investono in innovazione sostenibile, offrendo contributi concreti a chi sceglie di misurare — davvero — l’impatto ambientale dei propri prodotti.
In questo scenario, la Life Cycle Assessment (LCA) non è più solo uno strumento tecnico o normativo: è diventata una leva strategica per accedere a finanziamenti agevolati, migliorare il proprio posizionamento competitivo e dare concretezza agli impegni ambientali dichiarati. Presentare uno studio LCA conforme agli standard ISO e, ove previsto, alle regole PEFCR di categoria, può fare la differenza in fase di valutazione di un progetto: è un indicatore oggettivo, trasparente e verificabile della bontà delle scelte progettuali.

Non a caso, sempre più PMI e grandi brand del fashion system stanno integrando la LCA nei propri dossier progettuali, in particolare per partecipare a bandi per la transizione ecologica o l’efficientamento produttivo. Per le aziende tecniche e consulenziali, diventa quindi essenziale supportare i clienti non solo nell’adeguamento alle normative, ma anche nell’utilizzo strategico della LCA come chiave per accedere al capitale pubblico.
Un esempio concreto è il fondo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, che mette a disposizione oltre 30 milioni di euro a sostegno della filiera tessile. Il bando, attivo fino al 3 giugno 2025, prevede due linee di intervento principali:
- Crescita e innovazione: per investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva riducendo sprechi e impatti ambientali;
- Sostenibilità ambientale: per l’acquisto di beni strumentali, materiali riciclati e, soprattutto, per ottenere certificazioni ambientali di prodotto e processo.
Tra le spese ammissibili rientrano anche audit, consulenze e verifiche di conformità per certificazioni come l’EPD (Environmental Product Declaration) — una delle più solide e riconosciute certificazioni ambientali basate su LCA.
In un contesto sempre più attento e normato, saper dimostrare in modo trasparente e scientificamente fondato il proprio impatto ambientale non è più un plus, ma una condizione per restare competitivi. Ed oggi, finalmente, esistono strumenti concreti per rendere questa transizione non solo giusta, ma anche economicamente sostenibile.
Link utili:
-
MIMIT – Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia
-
Invitalia – Filiera tessile sostenibile
Immagini: Freepik; PEF Apparel & Footwear – The Product Environmental Footprint
Pubblicazioni correlate
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi le news dal mondo della moda etica e sostenibile. Innovazioni, ispirazioni, eventi, tendenze e materiali.