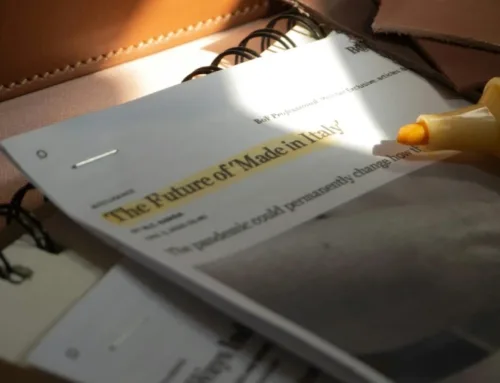Greenwashing: è tutto “verde” quel che luccica?
di rén collective

Di Rebecca Ravalli, con il contributo di Alessandra Ciarnó e Livia Caliopi Biro
Art. 34/2020 – Responsabile editoriale: Lorenza Vacchetto
Di greenwashing si parla molto, ne ha discusso recentemente anche la Commissione Europea attraverso la pubblicazione delle conclusioni dello screening dei siti web ‘sweep’, che quest’anno si è concentrato proprio sul greenwashing.
Il risultato dello sweep è piuttosto allarmante: quasi il 50% dei siti analizzati è risultato ‘’colpevole” di greenwashing. Mentre negli stati membri dell’Unione le autorità nazionali a tutela dei consumatori si occuperanno in questi mesi di andare in fondo alla faccenda, è bene che gli acquirenti finali inizino a fornirsi di strumenti che consentano loro di avvicinarsi al prossimo acquisto con un po’ di consapevolezza in più.
E dunque, da dove iniziare se non dal domandarsi di cosa si parla quando sentiamo la parola greenwashing?
Solitamente questo termine si riferisce a una pratica di comunicazione con la quale un brand e/o un’impresa lascia intendere all’acquirente di avere una reputazione ambientale migliore di quella che poi risulta essere dai fatti.
In quel ‘lascia intendere’ si annida tutto il difficile della vicenda. Infatti, il greenwashing può declinarsi in molte forme, non sempre del tutto riconducibili immediatamente a una fattispecie di pratica commerciale scorretta. Anzi, si potrebbe sostenere che il greenwashing risiede proprio al confine con questi casi di pratiche ingannevoli. Questo perché il greenwashing emerge da una verifica della corrispondenza tra fatti e quanto comunicato all’acquirente finale che è molto più complessa di quella che il codice del consumo richiede per l’identificazione di una pratica commerciale scorretta.

Il codice del consumo, infatti, si limita ad analizzare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da un brand riguardo qualità e altre caratteristiche dei prodotti e servizi destinati alla vendita. Tuttavia, questo potrebbe non bastare.
Per semplificare, guardiamo a 3 esempi come rappresentativi di 3 livelli di difficoltà nell’individuazione di un episodio di greenwashing:

Poiché le strategie di comunicazione si collocano in un discorso più ampio, che non riguarda solo il rapporto con i clienti, è molto improbabile che si riesca a risolvere il problema del greenwashing affidandosi solamente agli obblighi vigenti nella fase che antecede l’acquisto. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, l’informazione è il solo strumento che il cliente ha per acquistare seguendo i propri valori etici e morali: il giusto compromesso tra quantità e qualità dell’informazione è al momento l’unica guida alla portata di tutti.
Bisogna allora intervenire per contrastare il fenomeno del greenwashing per far si che i consumatori acquistino prodotti in linea con le proprie preferenze. Esistono già degli strumenti, in particolare, la normativa riguardante le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Un primo passo potrebbe dunque essere quello di potenziare i meccanismi esistenti, come le segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato creando delle sezioni specifiche per il greenwashing.

Una misura di cui si sente parlare tra gli addetti ai lavori riguarda poi l’introduzione di un sistema di etichettatura che indichi in maniera semplice ed efficace il livello di sostenibilità di un prodotto tramite l’attribuzione di diversi colori (verde, giallo e rosso). In questo modo, il colore dell’etichetta fungerebbe da indicatore della complessità dei parametri che devono essere tenuti in conto affinché un prodotto possa essere definito ‘sostenibile’.
Questo sistema, oltre al vantaggio di essere fruibile dal cliente finale, consentirebbe di tenere conto non solo di parametri specifici (per esempio sull’utilizzo delle materie prime, materiale usato per il packaging, risparmio energetico) ma anche della sostenibilità dell’intera catena di valore alla base della produzione del bene. Seguendo questa tendenza, in Francia la legge 105/2020 ha introdotto un sistema di etichettature volontario basato sul Life Cycle Assessment (LCA) dei prodotti, ritenuto, a oggi, il metodo più affidabile per valutare l’impatto ambientale di un prodotto.
Da ultimo, portare l’attenzione sull’intera catena di valore costituirebbe un primo passo verso il superamento della logica del ‘Made in’, sviluppatasi gradualmente a partire dagli anni ‘90 e arrivando a indurre gli acquirenti a ritenere che il Paese di origine determini la sostenibilità di un prodotto.
La soluzione al greenwashing è complessa perché complessi sono i meccanismi alla radice del fenomeno: tuttavia non è una battaglia impossibile da vincere soprattutto tenendo conto che le persone, in qualità di acquirenti, sono ogni giorno più esigenti in termini di trasparenza e credibilità da parte delle aziende che aspirano alla loro fiducia.
Articolo a cura di Rebecca Ravalli
Immagini: Luca Mendes, Jordan Beltran, Alena Koval, Katya Austin
Pubblicazioni correlate
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi le news dal mondo della moda etica e sostenibile. Innovazioni, ispirazioni, eventi, tendenze e materiali.